Come avevamo anticipato sul nostro blog lo scorso 30 aprile, in Darfur sono state usate armi chimiche. A confermare oggi le notizie che ci erano arrivate dai nostri contatti in Sudan e che avevamo tentato di verificare riscontrando grande ostracismo, è stato anche impedito alla nostra presidente, nonché giornalista, Antonella Napoli di tornare in Sudan è un rapporto di Amnesty International che riportiamo di seguito.
Post sul Corriere di Riccardo Noury, portavoce Amnesty Italia
Le prime denunce le aveva fatte circolare Italians for Darfur, l’associazione che nel silenzio generale cerca da 13 anni di mantenere alta l’attenzione sui crimini di guerra del regime del presidente-latitante (ricercato dalla Corte penale internazionale) Omar al-Bashir, col quale l’Italia non disdegna di fare accordi per i rimpatri.
Oggi arriva la conferma da parte di Amnesty International: da gennaio al 9 settembre 2016 sono stati condotti con ogni probabilità almeno 30 attacchi con armi chimiche nella zona del Jebel Marra. A questa sconvolgente conclusione, l’organizzazione per i diritti umani è giunta attraverso riprese satellitari, oltre 200 approfondite interviste con sopravvissuti e l’analisi da parte di esperti di decine di immagini agghiaccianti di bambini e neonati con terribili ferite. (Non mostriamo alcuna di quelle foto; questo post si apre con un’immagine di archivio sulle devastazioni dei villaggi del Darfur).
Le vittime da esposizione ad agenti chimici tra i civili darfuriani sarebbero dalle 200 alle 250. Molte, se non la maggior parte di loro, erano bambini.
Centinaia di altre persone sono inizialmente sopravvissute agli attacchi ma nelle ore e nei giorni successivi hanno sviluppato gravi disturbi gastrointestinali, tra cui diarrea e vomito di sangue; la loro pelle si è riempita di vesciche, hanno cambiato colorito, sono svenute, hanno perso completamente la vista e hanno sviluppato problemi respiratori che sono descritti come la principale causa di morte.
Molte delle vittime hanno dichiarato ad Amnesty International di non aver potuto accedere alle medicine e di essere state curate con sale, frutti ed erbe.
Un uomo che ha aiutato molte persone del suo villaggio e di quelli circostanti e che si prendeva cura delle vittime del conflitto nel Jebel Marra sin dal 2003, ha detto di non aver mai assistito a niente del genere: nel giro di un mese 19 delle persone che aveva curato, compresi dei bambini, sono morte. Tutte avevano sviluppato profondi cambiamenti sulla pelle: la metà delle ferite era diventata di colore verde e sull’altra metà si erano composte vesciche purulente.
Gli agenti chimici erano contenuti in bombe aeree e in razzi. La maggior parte dei sopravvissuti ha raccontato che il fumo rilasciato a seguito dell’esplosione cambiava colore nel giro di cinque, al massimo 20 minuti. Inizialmente era scuro, poi tendeva a diventare più chiaro. Tutti i sopravvissuti hanno descritto la puzza del fumo come estremamente nociva.
Amnesty International ha sottoposto le sue conclusioni a due esperti indipendenti in materia di armi chimiche. Secondo entrambi, vi è il forte sospetto che siano stati usati agenti chimici vescicanti, come mostarda solforosa, mostarda al nitrogeno o lewisite.
Gli attacchi con armi chimiche sono avvenuti durante l’offensiva su vasta scala lanciata a gennaio nel Jebel Marra dalle forze armate sudanesi contro l’Esercito di liberazione del Sudan/Abdul Wahid (Sla/Aw), accusato di imboscate contro convogli militari e attacchi contro i civili.
Negli otto mesi successivi al lancio dell’operazione militare Amnesty International ha documentato numerosi attacchi contro i civili e le loro proprietà. Le immagini satellitari hanno confermato che sono stati distrutti o danneggiati 171 villaggi, nella maggior parte dei quali non vi era presenza di oppositori armati al momento dell’attacco. In 250.000 hanno dovuto lasciare la zona.
Terra bruciata, stupro di massa, uccisioni e bombardamenti. Sono esattamente gli stessi crimini di guerra che vengono commessi dal 2004, quando il mondo si accorse per la prima volta che esisteva un luogo sulla terra chiamato Darfur: un luogo sprofondato da 13 anni in un catastrofico ciclo di violenza. Nulla è cambiato da allora, se non che il mondo ha cessato di occuparsene. Nonostante la presenza di una missione di peacekeeping congiunta delle Nazioni Unite e dell’Unione africana, la popolazione civile del Darfur continua a vivere nel terrore.




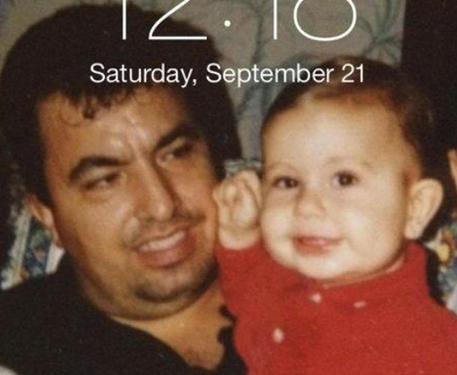
 (Foto su
(Foto su  sudafricana e appartenete al Black Consciousness Movement (BCM).
sudafricana e appartenete al Black Consciousness Movement (BCM).


