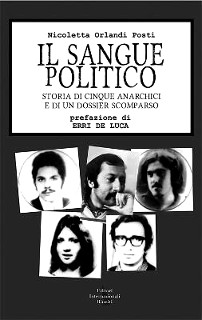1. “Quel bastardo è morto”
Elisei Marcello, di anni 19, muore alle tre di notte, solo come un cane alla catena in una casa abbandonata. Muore dopo un giorno e una notte di urla, suppliche, gemiti, lasciato senza cibo né acqua, legato per i polsi e le caviglie a un tavolaccio in una cella del carcere di Regina Coeli. Ha la broncopolmonite, è in stato di shock, la cella è gelida. I legacci bloccano la circolazione del sangue. Da una cella vicina un altro detenuto, il neofascista Paolo Signorelli, sente il ragazzo gridare a lungo, poi rantolare, invocare acqua, infine il silenzio. La mattina, chiede lumi su cosa sia accaduto. “Quel bastardo è morto”, taglia corto un agente di custodia. È il 29 novembre 1959.
Marcello Elisei stava scontando una condanna a quattro anni e sette mesi per aver rubato gomme d’automobile. Aveva dato segni di disagio psichico. Segni chiarissimi: aveva ingoiato chiodi, poi rimossi con una lavanda gastrica; il giorno prima aveva battuto più volte la testa contro un muro, cercando di uccidersi. I medici del carcere lo avevano accusato di “simulare”. Le guardie lo avevano trascinato via con la forza e legato al tavolaccio.
Il 15 dicembre si dimette il direttore del carcere Carmelo Scalia, ufficialmente per motivi di salute. A parte questo, per la morte di Elisei non pagherà nessuno. Inchieste e processi scagioneranno tutti gli indagati.
Leggendo della vicenda, Pier Paolo Pasolini rimane sconvolto. “Non so come avrei scritto un articolo su questa orribile morte”, dichiara alla rivista Noi donne del 27 dicembre 1959. “Ma certamente è un episodio che inserirò in uno dei racconti che ho in mente, o forse anche nel romanzo Il rio della grana”. Un romanzo rimasto incompiuto, poi incluso tra i materiali della raccolta Alì dagli occhi azzurri (1965). Se dovessi scrivere un’inchiesta, aggiunge, “sarei assolutamente spietato con i responsabili: dai secondini al direttore del carcere. E non mancherei di implicare le responsabilità dei governanti”.
Oggi è difficile, quasi impossibile cogliere la portata della persecuzione subita ogni giorno da Pasolini in 15 anni
L’agonia e la morte in solitudine di Marcello Elisei scaveranno a lungo dentro Pasolini, fino a ispirare il finale di Mamma Roma (1962). Ma nel 1959 Pasolini non è ancora un regista. Ha 37 anni, è autore di raccolte poetiche, sceneggiature e due romanzi che hanno fatto scalpore: Ragazzi di vita e Una vita violenta. Ha già subìto fermi di polizia, denunce, processi. Per censurare Ragazzi di vita si è mossa direttamente la presidenza del consiglio dei ministri. Eppure, a paragone dello stalking fascista, del mobbing poliziesco-giudiziario e del linciaggio mediatico che l’uomo sta per subire, questa è ancora poca roba.
Nel libro collettaneo Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte (Garzanti 1977) Stefano Rodotà riassume la questione in una frase: “Pasolini rimane ininterrottamente nelle mani dei giudici dal 1960 al 1975”. E anche oltre, va precisato. Post mortem. Rodotà parla di “un solo processo”, lunga catena di istruttorie e udienze che trascinò Pasolini decine e decine di volte nelle aule di tribunale, perfino più volte al giorno, tra umiliazioni e vessazioni, mentre fuori la stampa lo insultava, lo irrideva, lo linciava.
2. Il giornalismo libero
“Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia”.
L’uomo che nel giugno 1968 scrive questo verso ha già sulle spalle quattro fermi di polizia, 16 denunce e undici processi come imputato, oltre a tre aggressioni da parte di neofascisti (tutte archiviate dalla magistratura) e una perquisizione del proprio appartamento da parte della polizia in cerca di armi da fuoco. “Appena avrò un po’ di tempo”, scrive in un appunto inedito, “pubblicherò un libro bianco di una dozzina di sentenze pronunciate contro di me: senza commento. Sarà uno dei libri più comici della pubblicistica italiana. Ma ora le cose non sono più comiche. Sono tragiche, perché non riguardano più la persecuzione di un capro espiatorio […]: ora si tratta di una vasta, profonda calcolata opera di repressione, a cui la parte più retriva della Magistratura si è dedicata con zelo…”. E ancora: “Ho speso circa quindici milioni in avvocati, per difendermi in processi assurdi e puramente politici”.
Oggi è difficile, quasi impossibile cogliere la portata della persecuzione subita ogni giorno da Pasolini in 15 anni. La mostra Una strategia del linciaggio e delle mistificazioni, inaugurata nel 2005 e da poco riallestita alla sala Borsa di Bologna, restituisce appena tenui riverberi. Non può che essere così, per capire bisognerebbe calarsi nell’abisso – come ha fatto Franco Grattarola, autore di Pasolini. Una vita violentata (Coniglio 2005) – e ripercorrere la sfilza dei pestaggi a mezzo stampa. Toccare con le dita un’omofobia da sporcarsi solo a immaginarla. Soppesare l’intero corpus fradicio di articoli, denso come un grande bolo di sterco e vermi.
Tra i quotidiani si fa notare soprattutto Il Tempo, ma è la stampa periodica di destra a tormentare Pasolini in maniera teppistica e ininterrotta. Rotocalchi come Lo Specchio e Il Borghese si dedicano alla missione con entusiasmo, con reporter e corsivisti distaccati a tallonare la vittima, a provocarla, a colpirla in ogni occasione, con titoli come “Il c..o batte a sinistra” e lo stile inconfondibile oggi ereditato da Libero – per citare una sola testata.
Sulle pagine del Borghese si distinguono nel killeraggio il critico musicale Piero Buscaroli e il futuro autore e regista televisivo Pier Francesco Pingitore, fondatore del Bagaglino. Altre invettive giungono dallo scrittore Giovannino Guareschi e, in un’occasione, dal critico cinematografico Gian Luigi Rondi, ma la regina dell’antipasolinismo è senza dubbio Gianna Preda, pseudonimo di Maria Giovanna Pazzagli Predassi (1922-1981), poi cofondatrice – indovinate – del Bagaglino.
Celebrata ancora oggi su un blog di destra come “la signora del giornalismo libero”, “fuori dal coro”, “mai moralista né oscurantista” e via ritinteggiando, Preda coltiva nei confronti di Pasolini un’autentica ossessione omofobica, sessuofobica e – ça va sans dire – ideologica. Sovente si riferisce allo scrittore/regista chiamandolo “la Pasolina”. Per gli omosessuali, descritti come artefici di loschi complotti, conia il termine “pasolinidi”. Va avanti per anni – proseguendo anche dopo la morte di PPP – a scrivere cose del genere:
[Pasolini] ha potuto, con immutata disinvoltura, continuare a confondere le questioni del bassoschiena con quelle dell’antifascismo […] Una segreta alleanza […] fa dei ‘capovolti’ il partito più numeroso e saldo d’Italia; un partito che, attraverso i suoi illustri esponenti, finisce sempre col far capo o col rendere servizi al Pci […] Il ‘capovolto’ sente, a naso, quel che gli conviene e dove deve appoggiarsi, se non vuole rendere conto all’opinione pubblica di quello che essa giudica ancora un vizio […] Così nasce un nuovo mito… [A celebrarlo] pensano poi i giornali di sinistra, che riescono a camuffare da eroismo la paura segreta di questo o quel ‘capovolto’ clandestino. Luminose saranno le sorti dei pasolinidi d’Italia. Già si avvertono i segni delle fortune di coloro che hanno scoperto troppo tardi il vantaggio d’esser pasolinidi […] Se avremo, dunque, nuovi scontri con i marxisti […] prima di pensare a coprirci il petto, preoccupiamoci di coprirci le terga…
Il “metodo Boffo” giunge da lontano. E anche i complottismi sulla malvagia “teoria del gender”.
L’equivalente di Gianna Preda sullo Specchio è lo scrittore ex repubblichino Giose Rimanelli, celato dietro il nom de plume A. G. Solari. Com’è ovvio, attacchi forsennati a Pasolini giungono anche dal Secolo d’Italia, ma un lavorìo più subdolo e influente di character assassination ha luogo sulla stampa popolare nazionalconservatrice, quella di riviste come Oggi e Gente.
Si va molto più in là, purtroppo. Pasolini sembra essere la cartina di tornasole del peggio. Nel 1968 il regista Sergio Leone, interpellato dal Borghese, sente l’urgenza di commentare così le polemiche sul film Teorema: “Sono convinto che tanti film sull’omosessualità hanno fatto diventare del tutto normale e legittima questa forma di rapporto anormale”. Perfino su Il manifesto si trovano battute omofobe: “La tesi [di Pasolini] ridotta all’osso (sacro) è molto chiara…” (21 gennaio 1975). Come ha scritto Tullio De Mauro:
I fiotti neri finiscono con l’inquinare anche acque relativamente lontane. Il linguaggio verbale non è fatto solo di ciò che diciamo e udiamo. È fatto anche di ciò che, nella memoria comune, circonda e alona il detto e l’udito. Il non-detto pesa accanto al detto, ne orienta l’apprezzamento e intendimento. Chi legge nell’Espresso del 18 febbraio 1968 il pezzo Pasolini benedice i nudisti con foto di giovanotto ciociaro nudo a cavallo di violoncello, è coinvolto dagli effetti del fiotto nero d’origine fascista, gli piaccia o no e lo volessero o no i redattori del settimanale radical-socialista.
È una vasta campagna a favorire, o meglio, istigare non solo le azioni poliziesche e giudiziarie, ma anche le aggressioni fisiche da parte di fascisti. Fascisti mai toccati dalla magistratura, che poi finiranno in diverse inchieste sulla strategia della tensione, come Serafino Di Luia, Flavio Campo e Paolo Pecoriello.
Il 13 febbraio 1964, davanti alla Casa dello studente di Roma, una Fiat 600 cerca di investire un gruppo di amici di Pasolini che difendevano quest’ultimo da un agguato fascista. A guidare l’auto è Adriano Romualdi, discepolo di Julius Evola e figlio di Pino, deputato e presidente del Movimento sociale italiano (Msi). L’episodio è riportato con dettagli e fonti in tutte le biografie di Pasolini, mentre è assente dalla voce che Wikipedia dedica a Romualdi.
Pasolini non querela, né per le diffamazioni a mezzo stampa né per le aggressioni fisiche. È una scelta meditata: non vuole abbassarsi al livello dei suoi persecutori. Inoltre, se querelasse non farebbe che aumentare la già enorme quantità di tempo che trascorre in tribunale.
3. Come mai?
Come mai una simile persecuzione? Perché era omosessuale? Tra gli artisti e gli scrittori non era certo l’unico. Perché era omosessuale e comunista? Sì, ma nemmeno questo basta. Perché era omosessuale, comunista e si esprimeva senza alcuna reticenza contro la borghesia, il governo, la Democrazia cristiana, i fascisti, la magistratura e la polizia? Sì, questo basta. Sarebbe bastato ovunque, figurarsi in Italia e in quell’Italia.

Pasolini, ha scritto Alberto Moravia, scandalizzava quella “borghesia italiana che in quattro secoli ha creato i due più importanti movimenti conservatori d’Europa, cioè la controriforma e il fascismo”.
La borghesia italiana si è vendicata e, in modi più obliqui, continua a vendicarsi. La fandonia di “Pasolini che stava con la polizia”, ripetuta dai fascisti, dai perbenisti e dai falsi anticonformisti di oggi, prosegue la révanche dei fascisti, dei perbenisti e dei falsi anticonformisti di ieri.
Anche l’apologia postuma di un Pasolini semplificato, appiattito, lucidato e ridotto a santino fa parte della révanche.
4. “Non potranno mentire in eterno”
Nel marzo 1960 Fernando Tambroni, già ministro dell’interno e poi del bilancio, diventa capo di un governo monocolore Dc. L’esecutivo si forma grazie ai voti dei parlamentari missini. Appena quindici anni dopo la liberazione, una forza neofascista si avvicina all’area di governo. Proteste e disordini esplodono in tutto il paese. Il 30 giugno, decine di migliaia di manifestanti si scontrano con la polizia a Genova, città operaia e partigiana scelta dall’Msi per il suo congresso. Il 7 luglio, a Reggio Emilia, polizia e carabinieri sparano su una manifestazione sindacale uccidendo cinque persone. Il 19 luglio, Tambroni si dimette.
La rivista Vie nuove – su cui Pasolini tiene una rubrica dove dialoga con i lettori – produce all’istante un disco sull’eccidio di Reggio Emilia. Si tratta della registrazione della sparatoria. Su Vie nuove, anno XV, numero 33, del 20 agosto 1960, Pasolini commenta: “Quello che colpisce […] è la freddezza organizzata e meccanica con cui la polizia ha sparato: i colpi si succedono ai colpi, le raffiche alle raffiche, senza che niente le possa arrestare, come un gioco, quasi con la voluttà distratta di un divertimento”.
Sono i giorni del processo al criminale nazista Eichmann, e Pasolini collega le due storie:
Egli uccideva così, con questo distacco freddo e preveduto, con questa dissociazione folle. È da prevedere che le giustificazioni dei poliziotti […] saranno del tutto simili a quelle già ben note… Anch’essi parleranno di ordini, di dovere ecc. […] La polizia italiana… si configura quasi come l’esercito di una potenza straniera, installata nel cuore dell’Italia. Come combattere contro questa potenza e questo suo esercito? […] Noi abbiamo un potente mezzo di lotta: la forza della ragione, con la coerenza e la resistenza fisica e morale che essa dà. È con essa che dobbiamo lottare, senza perdere un colpo, senza desistere mai. I nostri avversari sono, criticamente e razionalmente, tanto deboli quanto sono poliziescamente forti: non potranno mentire in eterno.
Nel 1961 Pasolini gira il suo primo film, Accattone. In un paese dove si legge pochissimo, il cinema è potenzialmente più pericoloso della letteratura.
La riprovazione borghese, la censura e la repressione scatenate dai film di Pasolini (tutti, nessuno escluso) saranno incommensurabilmente maggiori di quelle scatenate dai libri e dagli articoli. Se poi in un film riemerge la storia di come morì Marcello Elisei…
Nel 1962, il finale di Mamma Roma – film che scatena violenze fasciste ed è subito proibito dalla censura – mostra il giovane Ettore che muore in prigione, gemente, febbricitante e invocante la mamma, legato in mutande e canottiera a un letto di contenzione. “Aiuto, aiuto, perché mi avete messo qua?… Non lo faccio più, lo giuro, non lo faccio più… So’ bono, adesso… Mamma, sto a mori’ de freddo… Sto male… Mamma!… Mamma, sto a mori’… È tutta notte che sto qua… Nun je ‘a faccio più…”.
Il 31 agosto 1962 il tenente colonnello Giulio Fabi, comandante del gruppo carabinieri di Venezia, denuncia Mamma Roma per oscenità e si premura di aggiungere: “Si fa presente che l’autore e regista Pasolini e uno degli interpreti, il Citti, dovrebbero avere precedenti penali presso il tribunale di Roma”. Tra coloro che seguono e apprezzano Pasolini circola l’ipotesi che a irritare l’arma sia stato il finale del film.
Da qui in avanti, Pasolini è investito da un’onda d’urto censoria e repressiva che non ha corrispettivi nella carriera di altri artisti italiani.
5. “Distruggere il Potere”
Ecco il senso dell’avverbio “ovviamente”, usato da Pasolini per rafforzare una premessa che ritiene importante. È del tutto ovvio che PPP sia contro l’istituzione della polizia.
Ancora più ovvio il verso che segue: “Ma provate a prendervela con la magistratura, e vedrete!”. Quella magistratura che tanto ha perseguitato, continua e continuerà a perseguitare Pasolini, anche dopo la morte.
È a partire da questa posizione che l’autore della poesia Il Pci ai giovani affida a un mucchio di “brutti versi” – definizione sua – una riflessione confusa, che deraglia subito e diventa uno sfogo, un’invettiva antiborghese. Come scriverà poco dopo: “Sono troppo traumatizzato dalla borghesia, e il mio odio verso di lei è ormai patologico”.
Ma per quanto l’invettiva possa essere brutta sul piano formale e carente di focus nei contenuti, dopo averla letta tutta (tutta intera, non solo i 4-5 versi estrapolati e branditi come randelli da questo o quello scagnozzo) è difficile concludere che “Pasolini stava con la polizia”.
Pasolini descrive i poliziotti che si sono scontrati con gli studenti a Valle Giulia come “umiliati dalla perdita della qualità di uomini / per quella di poliziotti”. L’istituzione della polizia disumanizza. Per questo gli studenti – “quei mille o duemila giovani miei fratelli / che operano a Trento o a Torino, / a Pavia o a Pisa, / a Firenze e un po’ anche a Roma” – sono comunque “dalla parte della ragione” e la polizia “dalla parte del torto”. Se non si capisce questo, non si coglie l’intento paradossale di Pasolini. Il paradosso gli serve a precisare che la vera rivoluzione non la faranno mai gli studenti, perché sono figli di borghesi. Al massimo potranno fare una “guerra civile”, in questo caso generazionale, in seno alla borghesia. La rivoluzione, dice Pasolini, possono farla solo gli operai, ai quali la grande stampa borghese non leccherà mai il culo, come invece – nell’iperbole pasoliniana – sta facendo con gli studenti. Sono gli operai il vero pericolo per il potere capitalistico, dunque saranno loro a subire la repressione poliziesca più pesante: “La polizia si limiterà a prendere un po’ di botte dentro una fabbrica occupata?”, si chiede retoricamente l’autore. Quindi, è proprio là che dovranno trovarsi gli studenti, se vogliono essere rivoluzionari: tra gli operai. “I Maestri si fanno occupando le Fabbriche / non le università”. Ma soprattutto, gli studenti devono riprendere in mano “l’unico strumento davvero pericoloso / per combattere contro i [loro] padri: / ossia il comunismo”. Pasolini li invita a impadronirsi del Pci, partito che ha “l’obiettivo teorico” di “distruggere il Potere” (quell’estinzione dello stato che Marx pone a obiettivo finale della lotta di classe e del socialismo) ma è finito in indegne mani, le mani di “signori in modesto doppiopetto”, “borghesi coetanei dei vostri stupidi padri”. Occupare le federazioni del Pci, dice Pasolini, aiuterebbe il partito a “distruggere, intanto, ciò che di borghese ha in sé”.
Questa esortazione occupa tutta la seconda metà del testo, ma – guarda caso – non viene mai citata.
Lo so, ti gira la testa. Ti avevano detto che Il Pci ai giovani parlava bene della repressione poliziesca. Hai sentito versi di questa poesia citati da pubblici ministeri mentre chiedevano pene pesantissime per i No Tav. Li hai uditi dalle labbra di Belpietro. Li hai letti nei comunicati del Sap e del Coisp…
6. Un infame mantra
Il Pci ai giovani fu attaccata subito, e non solo dagli studenti che criticava. Franco Fortini riempì Pasolini di insulti. Sotto il cumulo di quegli insulti, le critiche erano giuste. Pasolini provò a spiegarsi, cercando di non rimangiarsi il paradosso. Quei versi erano “brutti” perché non erano bastati “da soli a esprimere ciò che l’autore [voleva] esprimere”. Erano versi “’sdoppiati’, cioè ironici, autoironici. Tutto è detto tra virgolette”. Parlò di “boutade”, di “captatio malevolantiae”, ma non arretrò mai dal punto che aveva scelto e deciso di difendere: l’invito agli studenti a “operare l’ultima scelta ancora possibile […] in favore di ciò che non è borghese”.
Ma ormai la frittata era fatta e sarebbe rimasta a fumigare in padella per i quarant’anni e passa a venire, per la gioia di “postfascisti”, ciellini, sindacati gialli, teste da talk-show, scrittori tuttologi esternazionisti, commentatori pavloviani.
Ogni volta che si manifesta il conflitto sociale e la polizia interviene a reprimerlo riparte, come lo ha chiamato un cattivo maestro, “l’infame mantra” su Pasolini che stava con la polizia e i manganelli. Con quel mantra si è giustificato ogni ricorso alla violenza da parte delle forze dell’ordine. Bastonate, candelotti sparati in faccia, gas tossici, l’uccisione di Carlo Giuliani, l’irruzione alla scuola Diaz di Genova, la solidarietà di corpo agli assassini di Federico Aldrovandi eccetera. Periodicamente, frasi decontestualizzate sui manifestanti “figli di papà” e i poliziotti proletari sono usate contro precari, sfrattati o popolazioni che si oppongono alla devastazione del proprio territorio.
Ho però il sospetto che il mantra si sia imposto solo a partire dagli anni novanta, insieme a certe “appropriazioni” del pensiero di Pasolini. Sicuramente, nel periodo 1968-75 nessun detentore del potere, nessun membro del blocco d’ordine lesse quei versi come davvero apologetici della repressione. Basti vedere come proseguirono i rapporti tra Pasolini, la polizia e la magistratura, e come si evolsero quelli tra Pasolini, il movimento studentesco e le sinistre extraparlamentari.
7. “Propaganda antinazionale”
Nell’agosto 1968, due mesi dopo la polemica su Il Pci ai giovani, Pasolini partecipa alla contestazione contro la Mostra d’arte cinematografica di Venezia, occupa il palazzo del cinema al Lido, subisce lo sgombero poliziesco e si prende l’ennesima denuncia. Sarà processato insieme ad altri registi, con l’accusa di aver “turbato l’altrui pacifico possesso di cose immobili”. Verrà assolto nell’ottobre 1969.
Sulla rivista Tempo, anno XXX, numero 39, del 21 settembre 1968, la rubrica Il Caos tenuta da Pasolini contiene una “Lettera al Presidente del Consiglio”, che in quei giorni è Giovanni Leone, non ancora “quirinato” né impeached. Lo scrittore accusa il capo del governo per la repressione a Venezia. Quanti credono che Pasolini fosse contro il ‘68 e i contestatori trasecolerebbero leggendo questo passaggio (corsivo mio):
Nel ’44-’45 e nel ’68, sia pure parzialmente, il popolo italiano ha saputo cosa vuol dire – magari solo a livello pragmatico – cosa siano autogestione e decentramento, e ha vissuto, con violenza, una pretesa, sia pure indefinita, di democrazia reale. La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratiche-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline.
Leone risponde arzigogolando, Pasolini continua a mirare diritto e sul numero 41 del 5 ottobre 1968 ribadisce: “Io ero presente, quella notte. E ho visto coi miei occhi le violenze della polizia”.
Per chiedere – e il più delle volte ottenere – il sequestro delle opere di Pasolini agiscono in prima persona membri delle forze dell’ordine
Due mesi dopo, sul numero 52 del 21 dicembre 1968, Pasolini commenta l’ennesimo eccidio per mano poliziesca – due braccianti crivellati di colpi ad Avola, in Sicilia – e sostiene la proposta, fatta da un Pci ancora lontano dall’appoggio alle leggi speciali, di disarmare la polizia:
Disarmare la polizia significa infatti creare le condizioni oggettive per un immediato cambiamento della psicologia del poliziotto. Un poliziotto disarmato è un altro poliziotto. Crollerebbe di colpo, in lui, il fondamento della ‘falsa idea di sé’ che il Potere gli ha dato, addestrandolo come un automa.
In una puntata della rubrica rimasta inedita e ritrovata da Gian Carlo Ferretti, Pasolini risponde a una lettrice di destra, tale Romana Grandi, che gli ha inviato un volantino dell’Msi-Dn pieno di ingiurie nei confronti suoi e di altri intellettuali: “Un piccolo sforzo potrebbe pur farlo, visto che scrive e riscrive di essere una lavoratrice: non si è accorta che coloro che sono colpiti dalla polizia sono i lavoratori (e gli studenti che lottano accanto ai lavoratori)?”.

L’autunno del ’69 – il cosiddetto autunno caldo – è una stagione di grandi lotte e vittorie operaie. Il 12 dicembre, per tutta risposta, esplode la bomba in piazza Fontana. A ruota, parte la montatura per colpire gli anarchici, le sinistre e il movimento operaio. Il 15 dicembre muore Giuseppe Pinelli. Il 16 dicembre, l’inviato del Tg1 Bruno Vespa comunica a milioni di persone che “Pietro Valpreda è il colpevole, uno dei responsabili della strage di Milano”. L’anarchico Valpreda diventa il mostro.
Pasolini, Moravia, Maraini, Asor Rosa e altri intellettuali firmano un appello “contro l’ondata repressiva”. Sul Borghese del 28 dicembre 1969, Alberto Giovannini coglie la palla al balzo e scrive:
Tra gli arrestati, oltre al Valpreda, uso a voltare la schiena non solo all’odiata borghesia ma anche agli amati giovinetti, vi sono molti ‘travestiti’ e ‘checche’; e il fatto non può lasciare indifferente P. P. Pasolini, che dei capovolti di tutta Italia è, di certo, il padre spirituale, visto che la natura ingrata […] non gli ha consentito di esserne la madre.
Sul numero 2, anno XXXII, di Tempo, del 10 gennaio 1970, Pasolini si rivolge al deputato socialdemocratico Mauro Ferri e scrive:
L’estremismo dei gruppi minoritari ed extraparlamentari di sinistra non ha portato in nessun modo (è infame solo pensarlo) alla strage di Piazza Fontana: esso ha portato alla grande vittoria dei metalmeccanici. Prima che Potere Operaio e gli altri gruppi minoritari extra-partitici agissero, i sindacati dormivano.
Dal 1 marzo 1971, per due mesi, Pasolini si presta a fare il direttore responsabile del giornale Lotta Continua, accettando il rischio di essere inquisito, rinviato a giudizio e processato per i contenuti del giornale. Cosa che succede il 18 ottobre dello stesso anno, per avere “istigato militari a disobbedire le leggi […], svolto propaganda antinazionale e per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali costituiti dallo Stato [e] pubblicamente istigato a commettere delitti”. Pena massima prevista dal codice: 15 anni di reclusione. Testimoni per l’accusa: ufficiali, sottufficiali e agenti della pubblica sicurezza e dei carabinieri.
Dopo questo rinvio a giudizio, in spregio a qualsivoglia presunzione d’innocenza, la Rai blocca la messa in onda del programma di Enzo Biagi Terza B: facciamo l’appello. Oggi è una delle più famose apparizioni televisive di Pasolini, ma molti non sanno che fu censurata e andò in onda solo dopo la sua morte, cinque anni dopo essere stata registrata.
Nel frattempo, per chiedere – e il più delle volte ottenere – il sequestro delle opere di Pasolini agiscono in prima persona membri delle forze dell’ordine. A Bari, l’ispettrice di polizia Santoro segnala l’oscenità “orripilante” del film Decameron. Ad Ancona, contro la medesima pellicola sporge denuncia l’ispettore forestale Lorenzo Mannozzi Torini, secondo Wikipedia un “pioniere della tartuficoltura”.
Certamente provato ma per nulla intimidito, Pasolini finanzia e gira insieme al collettivo cinematografico di Lotta continua (Lc) un documentario-inchiesta su piazza Fontana e sullo stato delle lotte in Italia. Sceneggiato da Giovanni Bonfanti e Goffredo Fofi, il documentario esce nel 1972 con il titolo 12 dicembre e la dicitura “Da un’idea di Pier Paolo Pasolini”.
Ancora nel novembre 1973, quando il rapporto con Lc è teso e sull’orlo della rottura, Pasolini dichiara: “I ragazzi di Lotta continua sono degli estremisti, d’accordo, magari fanatici e protervamente rozzi dal punto di vista culturale, ma tirano la corda e mi pare che, proprio per questo, meritino di essere appoggiati. Bisogna volere il troppo per ottenere il poco”.
8. “Le nostre vecchie conoscenze”
L’ultima stagione, quella “corsara” e “luterana”, è segnata dalla reiterata, implacabile richiesta di un grande processo alla Democrazia cristiana, ai suoi dirigenti e notabili, ai complici delle sue politiche.
Dopo Il Pci ai giovani, sono alcune formule-shock del Pasolini 1974-75 a detenere il primato delle decontestualizzazioni e delle letture strumentali.
Per esempio, si estrapolano paradossi come “il fascismo degli antifascisti” per difendere le adunate di estrema destra, guardandosi bene dal dire che Pasolini usava l’espressione per attaccare l’ipocrisia del cosiddetto arco costituzionale, l’insieme dei partiti al potere, quelli che – dice in un’intervista del giugno 1975 – “continueranno a organizzare altri assassinii e altre stragi, e dunque a inventare i sicari fascisti; creando così una tensione antifascista per rifarsi una verginità antifascista, e per rubare ai ladri i loro voti; ma, nel tempo stesso, mantenendo l’impunità delle bande fasciste che essi, se volessero, liquiderebbero in un giorno”.
Senza il contesto cosa rimane? Una manciata di immagini – le lucciole, la fine del mondo contadino, i corpi omologati dei capelloni – ridotte a cliché e rese innocue. Rimane il “mito tecnicizzato” di uno pseudoPasolini light e lactose-free, propinato dalla stessa cultura dominante che perseguitò Pasolini, dagli eredi giornalistici dei suoi diffamatori e dagli eredi politici di chi lo aggrediva per strada.
L’8 ottobre 1975, sul Corriere della Sera, Pasolini commenta la messa in onda di Accattone da parte della Rai. Nel suo film d’esordio, scrive, metteva in scena due fenomeni di continuità tra regime fascista e regime democristiano: “Primo, la segregazione del sottoproletariato in una marginalità dove tutto era diverso; secondo, la spietata, criminaloide, insindacabile violenza della polizia”.
Nella polizia fascista di Madrid e Barcellona, scrive Pasolini, rivediamo la nostra polizia
Riguardo al primo fenomeno, scrive Pasolini, la società dei consumi ha “integrato” e omologato anche i sottoproletari, le loro abitudini, i loro corpi. Ergo, il mondo rappresentato in Accattone è finito per sempre.
È trascorso poco tempo, ma quelle parti di Roma sono cambiate. Pasolini le attraversa e dietro ogni incrocio, dietro ogni edificio, dietro ogni capannello di giovani vede – in una sovrapposizione lievemente sfasata – com’erano l’incrocio, l’edificio e quei giovani solo poco tempo prima. Tutto è in apparenza simile, ma la tonalità emotiva è alterata, la nota di fondo è irriconoscibile. Per un potente resoconto psicogeografico su tale “doppiezza” rimando alla passeggiata del Merda in Petrolio, Appunti 71-74a.
Ma cosa dice Pasolini del secondo fenomeno di continuità tra regime fascista e regime democristiano? “Su questo punto c’intendiamo subito tutti”, scrive, e sa di essere provocatorio. Sta parlando ai lettori del Corsera, è implausibile che tutti siano d’accordo nel ritenere “spietata” e “criminaloide” la violenza della polizia.
Ma l’autore è adamantino: “È inutile spendere parole. Parte della polizia è ancora così”. Segue un riferimento alla polizia spagnola, la guardia civil del regime franchista. Riferimento oggi incomprensibile, se non si sa cosa accadeva in Spagna in quei giorni. Ecco un titolo da l’Unità del 5 ottobre 1975: “Tortura a Madrid. / È stata usata dalla polizia franchista in modo sistematico contro non meno di 250 baschi. – Le conclusioni di un’inchiesta di Amnesty International – Testimonianze agghiaccianti”.
Il passaggio è rapido, ma non superficiale. Ci mostra un altro “doppio mondo” sfasato. Nella polizia fascista di Madrid e Barcellona, scrive Pasolini, rivediamo la nostra polizia, “le nostre vecchie conoscenze in tutto il loro squallido splendore”.
9. L’uomo che sorride
Tre settimane dopo, la notte tra il 1 e il 2 novembre, il corpo di Pasolini giace nel fango di Ostia, massacrato, ridotto a un unico cencio intriso di sangue.
Ora, per chiudere, prendo in prestito le parole di Roberto Chiesi:
Se guardate tra le terribili foto del ritrovamento del cadavere di Pasolini, ce n’è una, forse la più terribile, che mostra il corpo rovesciato e martoriato, con intorno alcuni inquirenti e poliziotti seduti sulle ginocchia. In particolare c’è un poliziotto seduto accanto al cadavere di Pasolini, che sorride. La foto lo mostra in maniera inequivocabile: è un sorriso di scherno, di disprezzo. Questa immagine può essere presa a campione di tutta un’Italia deteriore, da rifiutare, condensata in quell’immagine in bianco e nero, apparsa sulle prime pagine di tanti giornali dell’epoca.
Pasolini continuava a essere contro la polizia, la polizia continuava a essere contro Pasolini.
Fonte:
http://www.internazionale.it/reportage/2015/10/29/pasolini-polizia-anniversario-morte